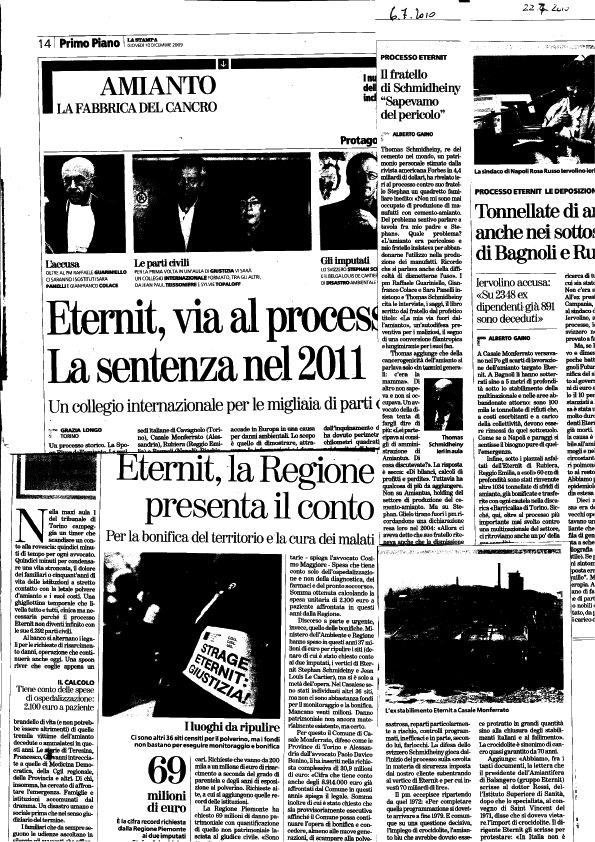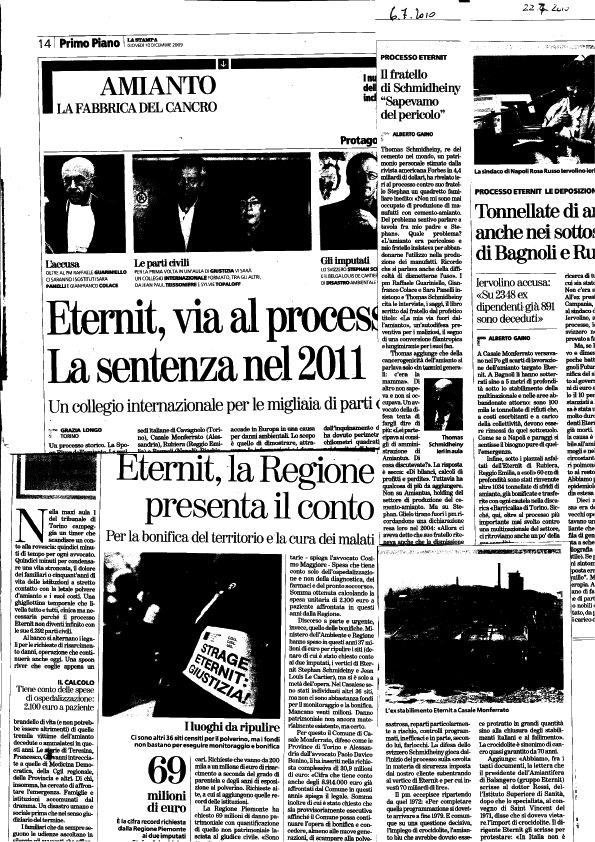
|
Il processo Eternit (vai agli articoli dei giornali) Il termine amianto deriva dal greco amíantos, incorruttibile e/o immacolato. La parola asbesto, in latino significa perpetuo ed inestinguibile. In edilizia, l'amianto ha trovato impiego associato ad agglomeranti come isolante elettrico e coibente termico, sotto forma di cartoni, feltri e tessuti; unito ad agglomerati di cemento (c.d. cemento-amianto o eternit - da eterno, riferito alla lunga durata, nome commerciale del fibrocemento, prodotto dalla società omonima, fondata nel 1906, composto di cemento portland a lenta presa impastato con fibre di amianto) è stato largamente impiegato nella produzione di lastre, tubi e relativi accessori, utilizzati nella prefabbricazione, negli impianti idrici e fognari, sfruttandone le caratteristiche di resistenza, leggerezza e impermeabilità. Nell'industria tessile, la fibra di amianto è stata largamente usata negli arredamenti esterni, per attrezzature da pompiere e per tute da lavoro: infatti i tessuti di amianto presentano importanti proprietà quali l'incombustibilità e l'elevata resistenza agli acidi. L’impiego dell’amianto è stato dapprima limitato dalle direttive CEE n. 478/83 e 610/85, quindi definitivamente vietato in Italia con la legge 27 marzo 1992, n. 257 che, all’art. 13, prevede che ai lavoratori occupati in imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, siano concessi un trattamento straordinario di integrazione salariale ed pensionamento anticipato: la Corte Costituzionale ha avvallato l’interpretazione più ragionevole di tale norma, riconoscendo la funzione compensativa e risarcitoria rispetto al bene salute, quindi “la finalità di offrire, ai lavoratori esposti all’amianto per un apprezzabile periodo di tempo (almeno 10 anni), un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene” (Corte Cost. decisioni 5/2000 e 127/2002). Un opposto orientamento giurisprudenziale ritiene, al contrario, che lo scopo della norma sia quello di tutelare il bene occupazione, nel senso di favorire il pensionamento di quei lavoratori che, a causa della cessazione dell’uso di amianto, avrebbero perso il posto di lavoro. Nel 2004, dopo la scoperta del legame tra la morte di un operaio residente in provincia di Torino, ad Orbassano, ma per anni impegnato a lavorare l’amianto in uno stabilimento Eternit in Svizzera, iniziano le indagini di quello che in molti considerano il più grande processo per disastro ambientale mai svolto in Europa. Numeri e persone Il 6 aprile 2009 si è aperto, presso il Tribunale di Torino, il processo penale nei confronti dei manager - proprietari della multinazionale Eternit. Gli imputati, lo svizzero Stephan Ernest Schmidheiny e il belga Jean Louis Marie Ghislain De Cartier De Marchienne, sono accusati dei reati di omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata (art. 437, comma 2 cp) e disastro doloso aggravato (art. 434, comma 2 cp).
Due imputati:
Stephan Schmidheiny (svizzero) e Jean
Louis De Cartier De Marchienne (belga)
Tre i giudici che compongono il
collegio giudicante: Giuseppe Casalbore (Presidente), Fabrizia Pironti e
Alessandro Santangelo (giudici a latere)
Tre i giudici che compongono il
collegio giudicante: Giuseppe Casalbore (Presidente), Fabrizia Pironti e
Alessandro Santangelo (giudici a latere) Settecentotrentotto e novantacinque i chilometri quadrati (ricadenti nei territori di ben quarantotto comuni) dell’area interessata direttamente dall’inquinamento da amianto, individuata dal Ministero dell’Ambiente relativa al solo stabilimento di Casale Monferrato. Seimila (circa) le parti civili ammesse, di cui 750 costituitesi all’udienza preliminare. Principali riferimenti giurisprudenziali
L'esposizione a fibre di amianto è
associata a malattie dell'apparato respiratorio (asbestosi, carcinoma
polmonare) e delle membrane sierose, principalmente la pleura (mesoteliomi)
. Valutare se sia imputabile in sede penale ai responsabili delle imprese il verificarsi nei propri lavoratori di patologie di cui è scientificamente nota la correlazione al contatto con l’amianto non è semplice (si veda ad es. Pasquale Saraceno , La decisione sul fatto incerto nel processo penale, Padova, 1940). Nella quasi totalità dei casi si tratta di forme di mesotelioma pleurico, una patologia di natura tumorale che conduce alla morte in brevissimo tempo dalla sua comparsa (le terapie normalmente utilizzate in ambito oncologico non sono in alcun modo in grado di contrastare la sua rapida evoluzione), e che come noto è tragicamente assai diffusa proprio tra i lavoratori esposti ad amianto.
Gli orientamenti espressi, sul tema
del nesso causale, dal giudice di legittimità in sede penale risultano
essere stati storicamente e fondamentalmente tre: Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza dell’11 luglio 2002, n. 30328 , (imp. Franzese, in Cass. Pen. 2003, 1175, con nota di Blaiotta) (altro link) Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 11 luglio 2002, n. 988, (imp. Macola e altro, in Foro it. 2003, 324ss, con nota di Guariniello) Sul rapporto tra il giudizio probabilistico e le leggi scientifiche di copertura può essere citata ancora Corte di Cassazione, Sezione IV, 22 novembre 2007-1° febbraio 2008, Orlando, in CED, n. 5117: ribadisce che “nell’accertamento della causalità generale, ovvero nella identificazione delle legge scientifica di copertura, il giudice deve individuare una spiegazione generale degli eventi basata sul sapere scientifico, sapere (come riaffermato anche dalla nota sentenza Franzese del 10 luglio 2002 di questa Corte) che è costituito non solo da leggi universali (invero assai rare), ma altresì da leggi statistiche, da generalizzazioni empiriche del senso comune, da rilevazioni epidemiologiche”, e afferma che “i giudici di merito in proposito non potevano non tenere conto della esistenza di un riconoscimento condiviso, se non generalizzato, della comunità scientifica - peraltro fatto già proprio da sentenze di merito e di legittimità (v., tra queste ultime, Sezione IV, 11 luglio 2002, Macola ed altro, in Dir.prat.lav., 2003, 16, 1057) - sul rapporto esponenziale tra dose di cancerogeno assorbita (determinata dalla concentrazione e dalla durata dell’esposizione) e risposta tumorale, con la conseguente maggiore incidenza dei tumori e minore durata della latenza della malattia nelle ipotesi di aumento della dose di cancerogeno”. Precisa, quindi, che “l’illogicità ed insufficienza della motivazione attiene le regole di valutazione (qui, le leggi scientifiche) scelte ed utilizzate per spiegare il fenomeno incriminato”, e che “il vizio di motivazione deriva dal fatto che i giudici di merito hanno trascurato di prendere in esame le generalizzate massime di esperienza nonché gli studi in materia, menzionati anche nei motivi di appello e nella consulenza delle parti offese, sulle conseguenze dell’esposizione all’amianto, anche con riferimento all’accorciamento del periodo di latenza del mesotelioma, recependo, invece, senza una convincente analisi critica, le argomentazioni del perito di ufficio, contraddittorie, per quanto sopra esposto”. In materia di continuità tra le leggi e specificamente fra il D.P.R. n. 547/1995 ed il Decreto legislativo 81/2008, può essere, infine, utile ricordare: Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza 7 maggio - 11 giugno 2009, n. 23976 (altro link) Corte di Cassazione, Sezione IV penale, sentenza 3 maggio 2010, n. 16761
Come è andata a finire? (Aggiornamento del 14.2.2012) Il giorno 13 Febbraio 2012, il Tribunale di Torino, nella persona del Presidente del Collegio, dott. Giuseppe Casalbore, ha dato lettura, per la durata di 3 ore, del dispositivo di sentenza nei confronti degli imputati. Gli imputati sono stati entrambi condannati alla pena di anni 16 di reclusione per disastro ambientale doloso (primo caso in Italia) e per omissione - anch'essa dolosa - di norme antinfortunistiche. In relazione a questo secondo reato, il Tribunale ha pronunciato, nei confronti degli imputati, una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione per tutti i fatti anteriori al 13.8.1999 (cioè 12 anni e mezzo prima della pronuncia di primo grado); analoga pronuncia si è avuta in relazione al disastro ambientale contestato in riferimento alla gestione degli stabilimenti di Rubiera (Reggio Emilia) e di Bagnoli (Napoli). Nonostante i suddetti "tagli" dovuti alla prescrizione, sono state riconosciute le richieste di circa 2.900 parti civili, oltre a quelle istituzionali (Regione Piemonte, vari Comuni piemontesi tra i quali Casale Monferrato, Inail, Inps, sindacati, associazioni di vittime...), e sono state concesse provvisionali, immediatamente esecutive, per il complessivo ammontare di 95 milioni di euro, oltre l'ulteriore liquidazione demandata al separato giudizio civile. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro il prossimo 13 Maggio 2012.
|